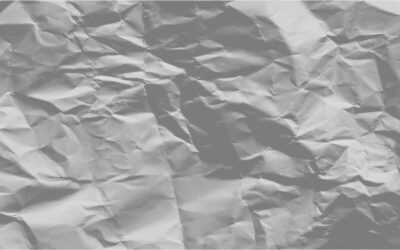Cos’è il cram down fiscale
Il cram down fiscale è una ristrutturazione del passivo tramite omologazione forzata della proposta di soddisfacimento dei creditori, anche in mancanza di adesione dei creditori stessi
Si parla di cram down fiscale (ristrutturazione forzata del passivo) quando un’impresa in crisi presenta una proposta per soddisfare parzialmente i creditori e il Tribunale decide di confermare o modificare il piano presentato anche se i creditori sollevano delle obiezioni al contenuto del piano del debitore. In genere si ricorre al cram down quando il Tribunale rileva che il debitore sta mettendo in atto un sforzo concreto per pagare i creditori, superare così un momento di crisi e riorganizzarsi per proseguire l’attività.
In genere il Tribunale fa da mediatore tra debitore e creditori per cercare un accordo e fare in modo che il piano venga votato e adottato, se però il Tribunale rileva che questo risultato non è perseguibile, può proporne uno proprio o chiedere ai creditori di elaborare loro un piano. Nel momento in cui il Tribunale approva il piano, anche senza avere l’appoggio dei creditori, il debitore deve attivarsi per rispettare il piano, perché se non lo fa il Tribunale può intraprendere azioni per tutelare gli interessi dei creditori.
Corte d’Appello di Bari del 4 dicembre 2024
La sentenza Corte d’Appello di Bari del 4 dicembre 2024 sostiene che il cram down fiscale si applichi non solo al concordato liquidatori, ma anche al concordato in continuità aziendale purchè il trattamento dei creditori dissenzienti non sia deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
Secondo una prima tesi, le disposizioni dell’art. 112 comma 2 si aggiungevano a quelle dell’art. 88 comma 2-bis del CCII, completandole, pertanto, il giudice poteva disporre il “cram down” tanto nel concordato liquidatorio quanto in quello in continuità indiretta, convertendo il voto negativo dei creditori pubblici (erario ed enti contributivi) in voto positivo.
Una diversa tesi riteneva, invece, che l’art. 112 comma 2 aveva valenza sostitutiva dell’art. 88 comma 2-bis, sul presupposto che tale norma richiamava il solo art. 109 comma 1, con la conseguente possibilità di omologazione “forzosa” unicamente per il concordato liquidatorio.
L’interpretazione estensiva ha trovato conferma con il c.d. correttivo-ter, che ha riscritto l’art. 88 del CCII, prevedendo che “Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall’articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Nell’ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l’adesione dei creditori pubblici deve essere espressa”.
La norma, quindi, prevede la possibilità di omologazione del concordato in continuità anche senza il consenso dei creditori pubblici, a condizione che il trattamento ad essi riservato non sia peggiore di quello che essi otterrebbero nell’alternativo scenario liquidatorio.
Tale modifica, con la quale il legislatore sembra aver perseguito lo scopo di porre fine agli animati contrasti dottrinali e giurisprudenziali sorti sulla questione – almeno per il futuro – costituisce, secondo i giudici, un non trascurabile indice normativo suscettibile di ineludibile valorizzazione nell’interpretazione del previgente art. 88, nel senso dell’ammissibilità del “cram down” anche per il concordato in continuità. La problematica di cui all’art. 112 del CCI in tema di omologazione mediante la c.d. “ristrutturazione trasversale” può essere intesa, quindi, secondo i giudici, nel senso che la proposta è approvata se tutte le classi dei creditori hanno votato favorevolmente (comma 1 lett. f).
Tuttavia, anche la proposta priva del consenso totalitario delle classi può essere omologata purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: il piano preveda che il valore di liquidazione venga distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, in osservanza del criterio ex art 84 comma 6 del CCII, secondo la regola della c.d. “priorità assoluta”; il valore eccedente quello di liquidazione (plusvalore o “surplus” da continuità aziendale) sia distribuito, secondo la regola della c.d. “priorità relativa”, cioè in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando il criterio di soddisfacimento sancito dall’art. 84 comma 7 per i crediti assistiti dal (super)privilegio di cui all’ art 2751-bis n. 1 c.c. (crediti di lavoro); nessun creditore riceva più dell’importo del proprio credito, al fine di evitare che il voto favorevole dei creditori sia “carpito” attraverso promesse di benefici aggiuntivi, in violazione delle regole del concorso; infine, la proposta, che non abbia ricevuto il consenso unanime, può essere approvata maggioritariamente purché una delle classi sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, prelazionari non soddisfatti entro centottanta giorni dall’omologazione ed integralmente in denaro, perché, diversamente, essi non sarebbero ammessi al voto per effetto dell’art. 109 comma 5, secondo periodo; oppure, in via alternativa, in mancanza di approvazione della maggioranza delle classi, la proposta “non consensuale” può essere ugualmente approvata con il “sostegno minimo” di almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause di prelazione anche sul plusvalore da continuità.